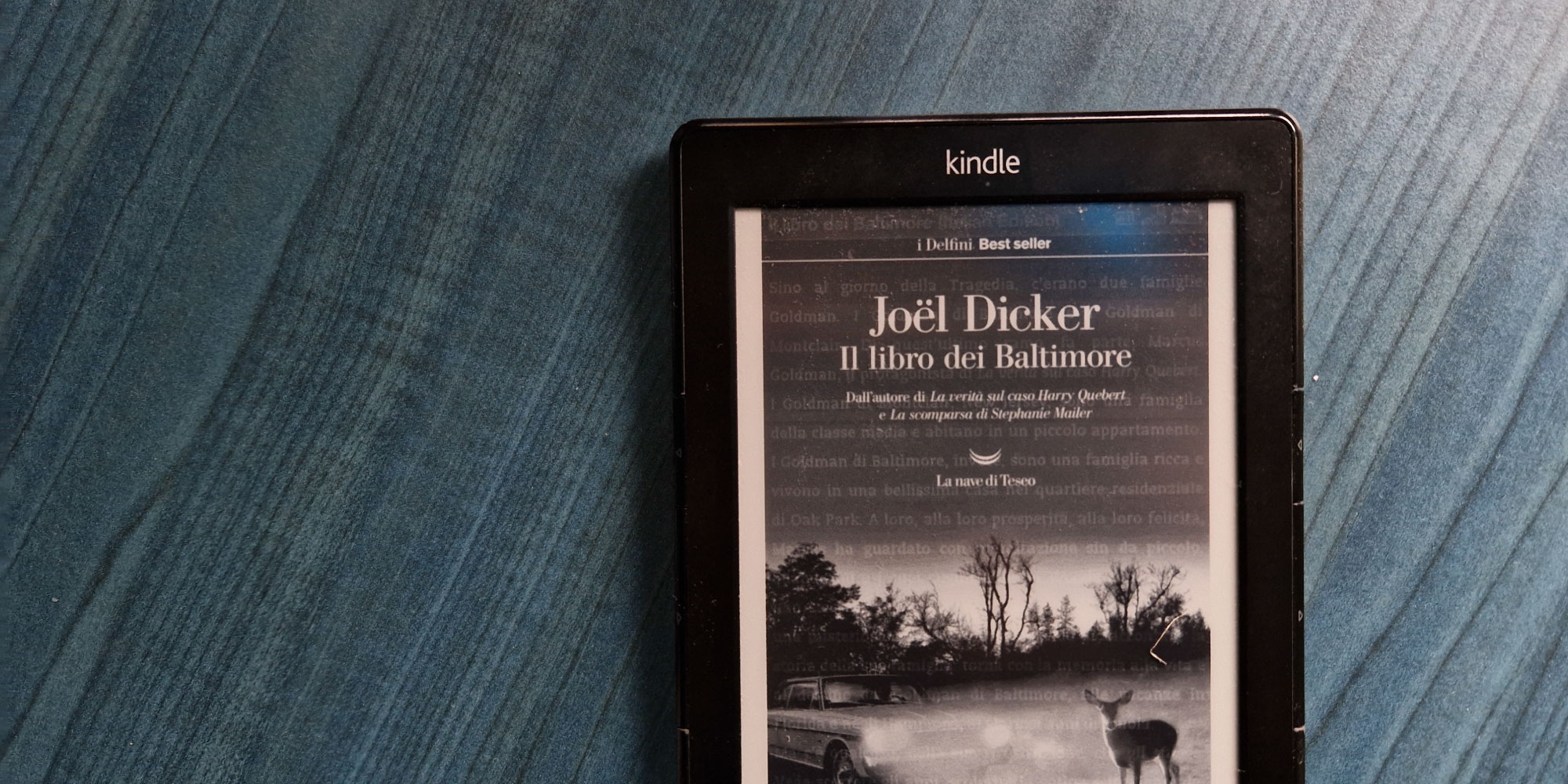Shirley, Shirley, ma cosa mi combini?
C’eravamo quasi, eravamo pronte a fare la pace io e te, ma hai sottratto la mano proprio all’ultimo, perché? Perché Shirley?
Caro lettore e cara lettrice, non sono definitivamente impazzita (anche se visti i ritmi lavorativi di questi ultimi giorni potrei anche non darlo così per scontato) ma sono reduce da una lettura che vi anticipo essere di valore.
E allora di cosa ti lamenti, direte voi?
Con calma, adesso vi spiego.
Avevo già “incontrato” Shirley Jackson, autrice statunitense di fama mondiale portata alla ribalta dalla grande pubblicità che ne ha fatto negli anni Stephen King, approcciandomi a due sue brevi opere, ovvero La ragazza scomparsa e La lotteria, entrambi editi Adelphi.
Entrambe le opere mi hanno fatto esprimere uno stanco “meh” a fine lettura in quanto, al netto della grande fama di Jackson, queste opere mi avevano comunicato poco. Ho supposto tuttavia che questa sensazione fosse data dall’estrema brevità di questi titoli (La ragazza scomparsa è addirittura una raccolta di tre racconti) così ho scelto di dare un’altra opportunità a questa scrittrice.
Recensione di Abbiamo sempre vissuto nel castello
Sono dunque giunta in questi giorni ad Abbiamo sempre vissuto nel castello, opera che si gioca il podio delle più lette, conosciute e amate dell’autrice, assieme a L’incubo di Hill House.
Abbiamo sempre vissuto nel castello racconta la storia di due giovani sorelle, Constance e Mary Kate (detta Merricat) Blackwood che, a seguito di un tragico incidente, vivono da sole all’interno della grande dimora di famiglia, tramandata di generazione in generazione assieme a tutti i corredi che essa contiene.
Le ragazze condividono la quotidianità con l’unico superstite della disgrazia che ha colpito e decimato la famiglia, lo zio Julian, gravemente menomato dall’accaduto tanto da renderlo non autosufficiente ed avergli assestato anche un grave danno a livello cerebrale, tanto che i suoi discorsi risultano spesso confusi e sconclusionati.
Fino ad ora ho parlato di incidente, ma sarebbe più corretto parlare di omicidio, plurimo per giunta, perché già dalle prime pagine si capisce che la morte dei membri della famiglia Blackwood è avvenuta in circostanze riconducibili alla responsabilità di una delle due ragazze, nello specifico tramite avvelenamento da arsenico inserito nella zuccheriera, dalla quale una sera si sono serviti tutti tranne Constance, che non ama lo zucchero nei mirtilli, e Marricat che quella sera era stata messa in punizione senza cena.
Proprio per questa atroce aura che avvolge la casa e la famiglia Blackwood, Constance e Mary Kate vivono isolate dal resto del paese, ove solo quest’ultima si reca per delle sempre più fugaci ma indispensabili commissioni, tentando di evitare gli sguardi e i sussurri dei paesani, i quali, da un lato la temono, dall’altro la compatiscono oppure la deridono.
Ma cosa rende questo romanzo un gioiello del genere gotico?
Cosa, in questa storia è stata in grado di comunicare terrore senza mostrare nulla, senza bisogno di sangue, violenza o creature sovrannaturali?
Lo sguardo, i dialoghi, i rituali.
Lo sguardo è quello di Mary Kate dato che la voce narrante è la sua, uno sguardo intriso d’odio e di diffidenza, nonché di desiderio di morte. Marricat è un personaggio enigmatico ma che ci destabilizza perché sembra vivere in un mondo tutto suo; su carta la ragazza ha diciotto anni ma si comporta come una bambina, adora seppellire cose, parla col gatto e fantastica di andare o trovarsi sulla luna.
Ne conseguono dialoghi assieme alla sorella che sfiorano il bizzarro e il grottesco, che percepiamo non essere “normali” e si sa, ciò che svia dallo standard di base ci spaventa, se poi ci aggiungiamo un misterioso omicidio e un’atmosfera onirica il gioco è fatto.
Infine, grande ruolo nella creazione dell’inquietudine sono i rituali. Sia Merricat che Constance sembrano schiave di routine e abitudini che le rendono simili a manichini orribilmente immobili e senza volto.
Merricat in particolare usa gli oggetti come amuleti magici che possano tenere lontani gli estranei, Constance si attacca morbosamente alla cucina, al preparare da mangiare, ai corredi casalinghi, alla pulizia. Elementi che in altre narrazioni avrebbero poca importanza se non il sentore di parole messe lì per riempire le pagine, in questo contesto contribuiscono a dare forma ad un’atmosfera cupa, misteriosa, disturbante.
In termini narrativi la tensione cresce in maniera inesorabile con l’arrivo in casa di un cugino, Charles, che sembra intenzionato a rompere il sinistro idillio. Naturalmente non vi svelo quali saranno gli effetti di questo arrivo, ma non faticherete ad immaginare che essi porteranno ad un climax inesorabile.
Ed ora, la nota dolente, il finale
É per questo che ce l’ho con te, Shirley, perché fino a pagina 186 (il libro conta 188 pagine) io ci ho creduto in una svolta, in un pugno allo stomaco, in una rivelazione, se non proprio un colpo di scena, almeno un piccolo, misero scioglimento della tensione che avevi creato. Invece no. Invece solo suggestione fino alla fine. Ok, lo accetto, ma ti sei giocata le cinque stelle, ma c’eri vicinissima, mancava davvero una frase, solo una.
In generale posso dire di essermi ricreduta su questa scrittrice dalla penna strepitosa e non posso che consigliare questo libro, ma non posso che provare a togliermi l’amaro che mi è rimasto in bocca con un muffin ai mirtilli (senza zucchero però).